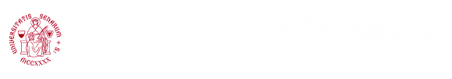Grazie al lavoro dei ricercatori dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Accademia dei Fisiocritici, il fiume Elsa è al centro di un importante progetto di recupero e riappropriazione sociale. Attraverso un approccio multidisciplinare che combina ricerca scientifica, strategie comunicative e partecipazione attiva, il progetto si propone di migliorare la conoscenza della biodiversità fluviale, promuovere una gestione sostenibile del territorio, supportare l’istituzione di un’area protetta e sensibilizzare la comunità e le amministrazioni locali sul valore del patrimonio naturale degli ecosistemi fluviali.
Il progetto “Università e Comunità insieme per tutelare la biodiversità” mira infatti a sensibilizzare cittadini, studenti e amministrazioni locali sul valore del patrimonio naturale degli ecosistemi fluviali, con particolare attenzione al fiume Elsa.

“Il fiume Elsa – spiega la professoressa Claudia Angiolini, docente del dipartimento di Scienze della Vita dell’Ateneo senese – che nasce dal versante occidentale della Montagnola Senese e scorre per circa 80 km prima di gettarsi nell’Arno, rappresenta una risorsa naturale e culturale di grande importanza per la Toscana”. “L’industrializzazione e lo scarico incontrollato di inquinanti ne hanno nel tempo compromesso lo stato ecologico, portando ad una progressiva perdita dell’uso sociale del fiume. A partire dagli anni ‘90, grazie alla pressione di associazioni e all’introduzione di normative stringenti, è iniziato un percorso di recupero ecologico e riappropriazione sociale, in cui l’Università di Siena ha svolto un ruolo chiave, avviando ricerche sulla biodiversità e sullo stato ecologico che hanno fornito le prime evidenze scientifiche sul valore naturalistico-ambientale di questo fiume”.
“Sulla scorta dell’esperienza di studio di anni, – prosegue Angiolini – il nostro progetto ha voluto portare la ricerca oltre l’ambito accademico, restituendo alla comunità i risultati scientifici e favorendone l’integrazione nelle politiche di gestione del territorio. Per promuovere una maggiore consapevolezza ecologica e facilitare il dialogo e la collaborazione con la comunità scientifica per una gestione condivisa del fiume, siamo passati attraverso la realizzazione di una serie di traguardi più specifici a livello locale: dal censimento e monitoraggio delle specie e degli habitat presenti, con particolare attenzione a quelle protette o in pericolo, all’analisi chimico-fisiche delle acque, gli indici ecologici, gli studi su contaminanti emergenti nelle acque e nei pesci bioindicatori, i biomarker per valutare l’impatto delle pressioni antropiche sull’ecosistema; da attività di educazione ambientale ed eventi di scienza partecipata alla costruzione delle basi scientifiche per supportare il percorso di istituzione di un’area protetta”.
 I ricercatori dell’Università di Siena, provenienti dai dipartimenti di Scienze della Vita, di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente e di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, con competenze che spaziano da botanica e zoologia ad ecologia e ecotossicologia, hanno condotto studi naturalistico-ecologici integrati e monitorato la qualità dell’acqua, la biodiversità e gli impatti ambientali. Hanno poi lavorato in modo sinergico col dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, con un focus specifico su condivisione dei risultati delle ricerche, promozione di azioni di tutela del territorio e soluzioni sostenibili per il miglioramento della qualità ambientale.
I ricercatori dell’Università di Siena, provenienti dai dipartimenti di Scienze della Vita, di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente e di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, con competenze che spaziano da botanica e zoologia ad ecologia e ecotossicologia, hanno condotto studi naturalistico-ecologici integrati e monitorato la qualità dell’acqua, la biodiversità e gli impatti ambientali. Hanno poi lavorato in modo sinergico col dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, con un focus specifico su condivisione dei risultati delle ricerche, promozione di azioni di tutela del territorio e soluzioni sostenibili per il miglioramento della qualità ambientale.
“La formalizzazione di questo lungo percorso congiunto – racconta Angiolini – è stata la sottoscrizione lo scorso 18 aprile del Contratto di fiume, pensato per tutelare e gestire il fiume Elsa e al tempo stesso valorizzarne il territorio, accompagnato da un accordo di programma sottoscritto da istituzioni, comuni, università e associazioni”.
All’interno del progetto sono stati organizzati incontri pubblici di divulgazione con ricercatori ed esperti, programmi educativi per le scuole tramite lezioni teoriche ed attività pratiche sul campo, eventi e progetti di Citizen Science.
 “Un esempio – spiega la professoressa – è l’iniziativa NATURE NAtura Urbana Elsa avviata nel 2021 ed ancora in corso, per la cui realizzazione ha avuto un ruolo chiave Debora Barbato, una giovane ricercatrice di UNISI. Ciò prevede la collaborazione di esperti e cittadini nella raccolta di osservazioni naturalistiche sulla piattaforma iNaturalist, per identificare e registrare il maggior numero possibile di specie e monitorare la qualità ambientale nell’area interessata. Il modello progettuale e partecipativo del fiume Elsa ha ispirato poi CS4RIVERS, un progetto nazionale di Citizen Science sugli ecosistemi fluviali guidato dall’Università di Siena (Spoke 3 del NBCF), finanziato dal PNRR e sviluppato da 16 partners tra istituzioni, associazioni e altri attori locali e nazionali.”
“Un esempio – spiega la professoressa – è l’iniziativa NATURE NAtura Urbana Elsa avviata nel 2021 ed ancora in corso, per la cui realizzazione ha avuto un ruolo chiave Debora Barbato, una giovane ricercatrice di UNISI. Ciò prevede la collaborazione di esperti e cittadini nella raccolta di osservazioni naturalistiche sulla piattaforma iNaturalist, per identificare e registrare il maggior numero possibile di specie e monitorare la qualità ambientale nell’area interessata. Il modello progettuale e partecipativo del fiume Elsa ha ispirato poi CS4RIVERS, un progetto nazionale di Citizen Science sugli ecosistemi fluviali guidato dall’Università di Siena (Spoke 3 del NBCF), finanziato dal PNRR e sviluppato da 16 partners tra istituzioni, associazioni e altri attori locali e nazionali.”
Le azioni sinergiche tra Università, cittadinanza, scuole e amministrazioni locali rappresentano un’esperienza significativa nelle politiche di conservazione, mirata all’inserimento di territori di valore conservazionistico nella rete di aree protette.
“La preziosa collaborazione delle varie forze in campo sul territorio – sottolinea Angiolini – ha permesso la realizzazione di due eventi inseriti nel programma della Bright Night, nelle edizioni 2022 e 2023. Ha inoltre dato impulso a importanti iniziative di comunicazione e informazione, come la presentazione ad AIDA Toscana nel 2023, quella al Pint of Science Festival a Siena e il convegno L’Università al servizio dei territori. Studi, ricerche e progetti per l’Elsa a Colle nel 2024″.
“I risultati globali del progetto – aggiunge – con la loro implicita importanza sia a livello economico che sociale, ci hanno permesso di proporre l’inclusione dell’ex ANPIL fiume Elsa nella Rete Natura 2000 e sono allineati con la Direttiva quadro sulle acque, che mira a raggiungere un buono stato chimico ed ecologico entro il 2027, e con l’agenda UE 2030, che prevede la tutela del 30% della superficie terrestre dell’Unione Europea”.
Sul piano accademico il progetto ha prodotto 4 pubblicazioni scientifiche, 3 tesi di laurea e 8 relazioni tecniche ed è stato presentato come caso studio in 5 simposi nazionali e 3 internazionali.